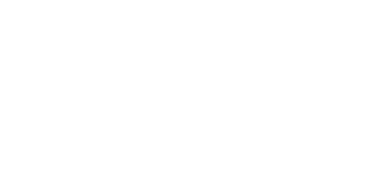Non si vive solo di cose e di gesti ma anche di idee. Non si mangiano solo oggetti nutrizionali ma anche valori, concetti, simboli.
Chi nel Medioevo o nel Rinascimento infarciva di spezie le proprie vivande non obbediva solo alle ragioni del gusto ma anche a quelle dell’immaginario. Le spezie indiane, provenienti da luoghi sconosciuti e misteriosi, oltre al gusto piccante possedevano il fascino dell’esotismo. Ed erano richiestissime sul mercato nonostante il costo proibitivo – o per meglio dire: a causa del costo proibitivo. Inaccessibili a chi non disponesse di molto denaro, le spezie diventarono un simbolo di ricchezza e di prestigio. Un segno di distinzione, quasi un obbligo per manifestare il proprio stato sociale. Un cuoco italiano del Cinquecento, Cristoforo Messisbugo, spiega che la quantità di spezie impiegata nella preparazione dei piatti deve essere proporzionale alla dignità del personaggio: più si è in alto nella scala del potere, più spezie debbono comparire sulla sua tavola.
La spezia più richiesta era il pepe, di tante diverse qualità; c’erano poi la cannella, la noce moscata, i chiodi di garofano, decine e decine di altri tipi diversi, molti dei quali oggi ci sono sconosciuti. I mercanti italiani, soprattutto veneziani, accumularono fortune sul commercio di questi prodotti.
Sul finire del Medioevo, tra le spezie fu incluso anche lo zucchero. Anch’esso importato dall’Oriente, anch’esso esotico e costosissimo, lo zucchero aggiungeva un tocco di dolce al piccante delle spezie. Anch’esso diventò un segno di distinzione sociale. Anch’esso si cominciò a spolverizzare sulla pasta, per renderla più saporita e più nobile.